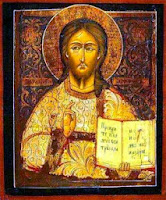«Dio non farà forse giustizia
ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse
aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,1-8).
La
parabola di oggi ci presenta un giudice disonesto: “bella novità”, diremo noi:
“sarà stato come uno dei tanti di cui anche noi oggi sentiamo tanto parlare”. Solo
però che a quell’epoca il compito specifico dei giudici era quello di tutelare
e difendere le persone più deboli, quelle che non potevano “farsi giustizia” da
sole: le vedove, i bambini e i poveri. In realtà però
nella stessa Bibbia troviamo esplicite condanne contro le ingiustizie commesse proprio con la
complicità e l’appoggio dei giudici. Quindi... niente di nuovo sotto il sole. Ma andiamo avanti.
È un
giudice, questo del vangelo, che non teme nessuno, se ne infischia altamente di quello che la gente
può dire in giro. Non ha una coscienza morale che gli procuri sensi di colpa per
quello che fa. Compie il male e, per lui, non c'è nessun problema.
C'è poi
una vedova, una persona onesta, povera, senza lavoro né protezione; una che non
aveva i soldi per “comprarsi” la sentenza. Ma era una “tosta”, decisa, testarda:
una che non intendeva assolutamente rinunciare al riconoscimento dei propri
diritti. Per cui tutti i giorni, puntualmente, si presentava dal giudice per
sollecitare la sua pratica.
Siamo dunque
di fronte ad una situazione apparentemente impossibile: il giudice è un
opportunista, uno che si fa i fatti suoi, che si muove solo “a pagamento”. La
donna soldi da dargli non ne ha. A questo punto cos’altro le rimane da fare se
non arrendersi?
La
maggior parte della gente infatti, di fronte ad una situazione del genere,
lascia perdere. Ed è vero, perché nella vita ci sono cose che sono veramente
insuperabili. Ma non è detto però che non si possano comunque affrontare.
Noi
diciamo troppo spesso: “Non ce la faccio!”. “Ma ci abbiamo almeno provato?”.
Perché spesso abbandoniamo l’impresa ancora prima di provarci, dopo il primo
tentativo andato male. È più facile per noi dire che una cosa è “impossibile” quando
è solo difficile oppure come non la vogliamo noi.
Ci rassegniamo,
o facciamo le vittime. Ma questo vangelo ci dice: “Provaci, non far finta;
provaci per davvero; non guardare alla difficoltà, fidati di te, delle tue
forze e soprattutto del fatto che Io sono con te; non so se ce la farai ma
lotta con tutto te stesso, come ha fatto quella donna”. Non fingiamo: proviamoci,
insistiamo, con tutte le nostre forze, usando tutte le strategie possibili.
La
strategia della donna non è molto ortodossa ma funziona: rompere le scatole!
Il
verbo greco Ãpwpi€zein letteralmente vuol dire “fare un occhio nero”, colpire, mettere alle
corde una persona; in senso figurato significa invece seccare, importunare, far fuori uno, farlo diventare “nero”. Per il
giudice la vedova è proprio una “rogna”, una scocciatrice.
Beh, non
è che dobbiamo proprio fare così alla lettera (ce ne sono già tante di persone
così in giro!); ma se ci teniamo ad una cosa, se una cosa per noi è importante,
allora dobbiamo usare tutte le strategie possibili.
Cosa
facciamo invece quando una nostra ingiusta situazione non viene neppure presa
in considerazione? Cosa facciamo quando qualcuno ci dice un no? Facciamo un
tentativo, due, tre, e poi smettiamo; ci sentiamo vittime che non possono fare
niente. Invece questa parabola ci indica un comportamento diverso: “Insisti,
rompi le scatole, sii insistente, assillante”. In-sistere vuol dire “stare in
quella cosa”: non arrenderci. Ci teniamo e non ci muoviamo da qui.
Insistere,
aver tenacia, non arrendersi, è la dimostrazione di quanto noi crediamo in una
cosa, di quanto ne siamo coinvolti, di quanto quella cosa sia importante per
noi. Lottare significa impiegare tutte le nostre energie per ciò che è
importante. Lottare è credere che Dio ci dà una mano. Lottare è avere fiducia
che con Lui troveremo una soluzione; vuol dire, in breve, “credere”, aver fede!
Fede
non è dire: “Dio, fa' come voglio io”. Questo è delirio di onnipotenza, è imporre
a Dio la nostra volontà! Fede è invece essere certi che con il suo aiuto c'è sempre
una possibilità, un modo alternativo per affrontare e risolvere la situazione.
Lottare,
infine, vuol dire anche: “Mi amo!”. Se mi amo, lotto per me. Lotto perché io
sono importante e mi sento tale. Ogni volta che rinunciamo ad un nostro
diritto, che rinunciamo ad esprimerci, a farci sentire, stiamo lentamente
uccidendo noi stessi. Perché gli altri dovrebbero rispettarci se poi neppure
noi lo facciamo? Se ci amiamo, se teniamo a noi, dobbiamo lottare per noi
stessi.
La
situazione della vedova sembrava già persa in partenza. Eppure lei ha una cosa
che fa la differenza: la fede. Lei è la parte ferita, la parte lesa, la parte vulnerabile,
quella che sente le emozioni. Ma questa donna, pur non sapendo come, né quando,
“sente” dentro di sé la fiducia che qualcosa deve cambiare e agisce in
conseguenza.
La
vedova ci rappresenta, è una parte di noi. Ma dentro di noi c'è anche il
giudice. È quella voce che ci dice: “Zitto; mettiti in un angolo!; non pensare
sempre a te!; c'è chi sta peggio di te!; devi adattarti, devi subire, devi portare
pazienza”. Ma con questo sistema ci dichiariamo disponibili a subire qualunque
imposizione, qualunque soperchieria. Le atrocità della vita accadono per due
motivi: uno perché c'è chi le compie; due perché c'è chi, pur sapendolo, non
dice nulla, non si oppone.
Nel
vangelo la vedova interviene invece con forza: “Non me ne sto zitta proprio per
niente! Rivendico i miei diritti; rivendico il mio diritto di parola; rivendico
la mia dignità; rivendico il rispetto per la mia persona. Per niente al mondo
tu, o giudice, mi chiuderai la bocca; io voglio che la mia situazione, le mie
emozioni, i miei diritti, siano considerati e rispettati”.
La
cosa peggiore che noi possiamo fare a noi stessi è di metterci il bavaglio,
condannarci al silenzio forzato, essere rinunciatari. Non è umiltà, è abulia. Non
uccidiamoci, ma amiamoci. Dio ci ha creati perché fossimo sue creature, perché
esistessimo, perché realizzassimo in noi l’opera del suo amore: diamoci e
diamogli spazio, diamoci e diamogli voce. Dimostriamo a tutti che ci sentiamo
realmente creature di Dio, consapevoli della nostra dignità, del nostro essere persone
all’altezza di quel progetto divino al quale Lui ci ha chiamati. Amen.
«Gli vennero incontro dieci
lebbrosi… “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre essi andavano, furono
purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un
Samaritano» (Lc 17,11-19)
Il
vangelo racconta di dieci guarigioni e di un solo miracolo: dieci lebbrosi
vanno da Gesù e vengono guariti, ma uno solo si rende conto di ciò che gli è
successo, solo in lui avviene il miracolo. Perché “guarire” è molto più che acquistare
la guarigione corporale; “guarire” significa compiere una trasformazione, una
conversione interiore.
Gesù dunque
entra in un villaggio e gli vanno incontro dieci lebbrosi. La lebbra, allora,
era considerata la peggiore delle malattie, non tanto per gli effetti
devastanti sulla persona, quanto per le conseguenze sociali che comportava: il
lebbroso per la società era un morto vivente, non poteva avere più
comunicazione sociale con nessuno, era un isolato, un escluso. Avere la lebbra
era una sentenza di morte lenta. Era il sacerdote che, in caso di guarigione, aveva
il compito di esaminare il lebbroso, di dichiararlo puro, cioè guarito. Allora
il guarito si sottoponeva a tutta una serie di riti e poteva essere reintegrato
nella società.
Qui
Gesù – contrariamente al suo normale comportamento negli altri casi di
guarigione - non fa nulla: non li tocca, non li guarisce immediatamente, non si
informa su di loro. Li manda semplicemente dai sacerdoti, ancora malati, ancora
lebbrosi,. Perché? Non poteva guarirli subito? O la loro guarigione dipendeva
proprio dall'andare dai sacerdoti? In effetti è così: questi dieci credono alla
parola di Gesù, hanno fede e questa loro fiducia li guarisce.
La
fede di questi dieci è che sono convinti di poter guarire, di poter cambiare la
loro situazione, e così avviene. Non è semplice per loro presentarsi a
quell’autorità che li rifiutava proprio per la loro malattia: ma essi, anche se
si vergognano della loro condizione, sfidano il giudizio pubblico e sociale, sfidano
il rifiuto di quelle persone e vanno comunque da loro. Il segreto della loro
guarigione sta qui: nell’aver recuperato la fiducia in sé e nell’andare incontro
proprio a quelle situazioni che temono di più.
Se noi
non crediamo in qualcosa di migliore per noi, non ci può succedere nulla di
migliore. Se noi non crediamo che Dio ci ama, se dubitiamo, se siamo scettici,
Dio non può trasformarci. Se noi non crediamo che possiamo guarire, non guariremo!
Molte
persone non cambiano la loro vita, le loro malattie, le loro paure, i loro
comportamenti negativi, perché non credono che “ la guarigione” possa succedere
proprio a loro.
Quando
ci sentiamo in colpa, il nostro impulso è quello di scappare, di nasconderci,
di evitare incontri. Gesù invece ci dice: “Fuori”. “Hai paura di andare? Ebbene:
è proprio lì che devi andare! Vai, apriti, fatti vedere, chiedi e non vergognarti”.
Ai
lebbrosi che invocavano la sua misericordia, Gesù non dice: “Andate nel tempio e
fermatevi lì a pregare”, ma: “Andate dai sacerdoti”. È l’azione che è
richiesta; non una staticità passiva, un’attesa rassegnata; la loro preghiera
deve diventare movimento, energia. Pregare è agire, altrimenti la preghiera rimane
un lamento inutile, una filastrocca arida. Pregare è uscire, combattere, affrontare
ciò che temiamo; è muoversi, è cambiare, fare ciò che Lui ci ha detto.
Non cadiamo
nel qualunquismo religioso, non facciamo del nostro credo, del nostro vangelo, della
Parola di Dio, solo una egoistica sintesi personale di ciò che ci fa comodo. I
miracoli avvengono, ma solo se noi crediamo in Dio con fede autentica, intima, cristallina;
altrimenti Lui non può farci nulla. Non basta sperarlo, non basta desiderarlo, non
basta volerlo ardentemente: il miracolo, la guarigione, avviene solo se ci
crediamo.
Tutti e
dieci i lebbrosi guariscono, ma uno solo torna indietro a ringraziare. Perché?
Non erano stati guariti tutti e dieci? Il vangelo spiega che “uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro”. Ebbene:
è proprio quel “vedendosi” che è decisivo. Uno di loro “vede”, si accorge di
ciò che gli è successo: se ne rende conto, riconosce la fortuna, la
benedizione, la grandezza di ciò che gli è successo. E gli altri? Degli altri
non si dice che abbiano visto.
Gli
altri nove hanno eseguito l’ordine di Gesù e sono andati dai sacerdoti: hanno obbedito
all’ordine e si sentono a posto. Ma questa è la religione del “contabile”: tu
mi comandi una cosa, io la faccio e siamo pari. Non si sono accorti del dono; non
sono stati toccati nel profondo. Sono stati guariti dalla malattia ma non sono
cambiati dentro. Sono stati guariti ma non hanno visto Dio. Non c'è stato
sussulto, meraviglia, lode, ringraziamento in loro; avevano sete, hanno
ricevuto il bicchiere d'acqua e si sono accontentati, tutto è finito lì. Non
sono stati neppure sfiorati dal desiderio di andare oltre, di raggiungere la
sorgente, la fonte, la forza che li aveva guariti.
Il ritorno
del samaritano è il segno che lui solo ha “visto”; ha capito cioè di aver
ottenuto un qualcosa di molto prezioso che non gli era dovuto. E per questo “ritorna”
per ringraziare Gesù.
Le
persone pensano che tutto sia dovuto. Hanno pretese smisurate, esagerate,
eccessive, nei confronti degli altri, e di se stessi: i privilegi non bastano
mai. I nove lebbrosi hanno avuto anch’essi un dono grandissimo, ma non se ne sono
accorti, non se ne sono resi conto; è stato come se non l'avessero avuta! E non
sono tornati a ringraziare, a rendergli gloria: un’azione strettamente collegata
all’accorgersi, all’essere consapevoli, al rendersi conto di ciò che succede, di
ciò che capita, di ciò che avviene in loro e attorno a loro.
Il
verbo “rendere gloria”, in greco, è strettamente collegato all’accorgersi,
L’uomo
in questo è particolarmente distratto. È refrattario alla riconoscenza.
Così la
nostra “eucarestia” (dal greco eÇcar°zw, ringraziare, rendere grazie)
dovrebbe essere il modo migliore per “rendere grazie” a Dio, per ringraziarlo
della sua costante presenza nella nostra vita.
Ma le
nostre eucaristie domenicali sono troppo spesso senz'anima; rischiano di essere
un precetto, un'osservanza; sono senza festa, senza vitalità, senza passione.
Sono un'ordinaria amministrazione, un inno all'indifferenza: non “vediamo”, non
ci rendiamo conto del passaggio di Dio, non sappiamo vedere cosa Egli fa per
noi, non c'è sussulto nel nostro esserci.
L'egocentrismo
delle persone si manifesta nella mancanza di gioia e di festa nella loro vita: non
si accontentano mai, pensano di non ricevere mai abbastanza; sono sempre
fissati su quel qualcosa che ancora non hanno. Dio, la società, gli altri, sono
sempre colpevoli di non dar loro di più.
Il
miracolo è invece rendersi conto, percepire che niente ci è dovuto, che niente
è un diritto. “Ringraziare, grazia, gratitudine”, provengono infatti dalla
stessa parola: “gratis”.
Tutto
ciò che abbiamo e siamo, è gratis. Non ce lo meritiamo e non ci è dovuto: tutto
è solo un dono. Apprezziamolo e ringraziamo Dio: ringraziamolo per i figli, non
ci sono “dovuti”, sono un dono; ringraziamolo per l'amore, non ci è dovuto, ma è
un dono; ringraziamolo per la vita, non ci è dovuta: è un dono. Godiamo di
questi doni, godiamo di essere sue creature, frutto del suo amore: godiamo del
sole che ci riscalda, della strada su cui camminiamo, degli uccelli che ogni
mattina cantano, del respiro che pulsa e del cuore che batte in noi; godiamo
perché siamo vivi, perché possiamo parlare, perché possiamo esprimerci, perché possiamo
piangere. Ringraziamo Dio per gli amici, per le occasioni che abbiamo, per le
possibilità di vita che ci ritroviamo. Tutto questo per noi è gratis. Ringraziamo
Dio, perché nulla ci è dovuto. Ringraziamolo perché tutto ciò che avviene, tutto
ciò che ci riguarda, è un dono miracoloso del Suo amore.
Chi
non ringrazia, dimostra di non conoscere Dio. E non conoscendolo, si auto esclude
dal rendergli lode. Al contrario “tornerà indietro” a ringraziare, a “bene-dire”, a
lodare Dio, colui che si rende conto di
essere una insignificante particella di un immenso, meraviglioso mosaico; di appartenere
cioè ad un mistero divino di amore incalcolabile, un mistero che lo trascende,
che lo supera vorticosamente, nel quale si sente totalmente immerso.
Fare
della nostra vita una lode perenne a Dio: è questo il senso della nostra vita.
E ciò non significa esibire costantemente un sorriso beota stampato in faccia
(oltretutto indice di grande falsità); ma significa dire sempre di sì a Dio;
significa accoglierlo e dargli voce in tutti gli istanti della nostra vita. Una
vita di lode è la vita di colui che non si sottrae alla Sua volontà; di colui che
continua a “tornare” alla sua presenza; di colui che, dal suo profondo, gli innalza
lode per tutto ciò che vive, in segno di umile ringraziamento. Perché egli ha veramente
“visto”. Amen.
«Gli apostoli pongono a Gesù
una domanda: “Aumenta la nostra fede”... Il Signore rispose: Se aveste fede
quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: Sradicati e vai a piantarti
nel mare, ed esso vi obbedirebbe»
(Lc 17,5-10).
Nel
vangelo di oggi gli apostoli chiedono a Gesù di aumentare la loro fede. Il
fatto che gli chiedano una cosa del genere, sta ad indicare che nel loro animo
sentono il bisogno di crescere, di maturare, di capire; dopo i discorsi fatti
da Gesù in precedenza, essi si rendono conto di non aver afferrato il vero
senso delle sue parole, di essere ancora terra terra, di avere ancora tantissima
strada da fare. Indiscutibilmente una prova di umiltà, la loro. Se anche noi arrivassimo
a provare sinceramente una simile necessità, beh, significherebbe che stiamo già
a un buon punto del nostro cammino. Sarebbe quanto meno una concreta presa di coscienza
dei nostri limiti.
Gesù a
tale richiesta, tuttavia, non risponde né sì né no; e non dice neppure cosa dovrebbero,
o non dovrebbero fare, per raggiungere una maggior comprensione del suo
annuncio; si limita semplicemente a indicare alcune possibilità estreme,
realizzabili con una fede veramente autentica: un modo per metterli in
condizione di fare da soli delle considerazioni, di fare un'autoverifica sulla portata e
l’autenticità della loro fede: «Se aveste
fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sradicati e
vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe».
Un
granello di senape è veramente poca cosa, è minuscolo, insignificante, quasi
invisibile: salvo poi, una volta seminato e messo a dimora, crescere
rapidamente a dismisura, per diventare, nell'arco di un solo anno, una pianta alta
anche tre o quattro metri. Il gelso, invece, è un albero secolare, che può
vivere anche seicento anni; ha radici molto profonde, che si abbarbicano tenacemente
nella terra. È un albero molto difficile da sradicare, è simbolo di solidità,
di staticità, di inamovibilità. Ora, che un gelso si sradichi dal suo posto e
si radichi addirittura nel mare, beh non solo è difficile, ma sicuramente impossibile!
Eppure
– dice Gesù – basta una fede minima, purché autentica,
sincera, trasparente, per rendere possibile anche l’impossibile.
In altre
parole, nessun ostacolo, di qualunque natura, può arrestare il cammino di chi
ha un po’ di fede.
Nel
vangelo troviamo molti riferimenti sulle possibilità della fede: “Tutto è
possibile per chi crede”; “la tua fede ti ha salvato”; “chi ha fede sposta le
montagne”; “credete e tutto ciò che chiederete vi sarà dato”, ecc.
Ma
come facciamo a misurare la qualità della nostra fede, se abbiamo veramente fiducia
in Dio e nella Vita? Semplice: basta guardare a come reagiamo di fronte agli
ostacoli che incontriamo.
Abbiamo
un problema da affrontare e da risolvere nella nostra vita? Se abbiamo anche un
briciolo di fede vera (il granello di senapa!) riusciamo a fare miracoli,
anche enormi.
Dobbiamo
spostare il “gelso”, l’albero possente, inattaccabile, che ci sbarra la
strada? Il primo impatto ovvio è di esclamare: “Impossibile! Non ce la farò mai! È troppo
grande”. Ma il gelso, in fin dei conti, altro non è che la nostra paura di cambiare,
la paura dell’ignoto, del non sapere cosa ci accadrà poi; il timore di non
essere all’altezza, di non avere le forze per reggere; la paura di guardarci
dentro; la paura di affrontare quelli che temiamo, quelli che consideriamo
superiori; la paura che ci fa mendicare amore per non rimanere soli; la paura
di diventare impopolari, di essere derisi per aver fallito il nostro
inserimento nella società,; la paura di una malattia improvvisa e mortale...
Ma niente
è impossibile, niente insuperabile, niente insopportabile: basta solo un po' di
fede. Dobbiamo solo iniziare, darci da fare, metterci in movimento: e poi scopriremo
che il nostro iniziale barlume di fede diventerà ben presto enorme (il piccolo
seme che diventa un albero rigoglioso) e compirà l'impossibile.
Quante
volte ci lamentiamo anche noi con Gesù: “Ho poca fede! Così non ce la faccio,
non ci riuscirò mai, aumenta Tu la mia fede!”. E quante volte Lo abbiamo puntualmente
sentito nel nostro cuore rassicurarci: “Lo so che ne hai poca, è normale.
Fidati di quel poco che hai! Fallo crescere! Nutri quel poco che c'è in te... e
vedrai!”.
Aver
fede non vuol dire pregare: la fede non sono le “nostre” preghiere. La fede è fiducia,
convinzione, certezza, percezione interna di essere amati, di essere degni
d'amore, di essere protetti e di avere la forza per affrontare ciò che abbiamo
davanti. La fede non è quello che sappiamo ma quello che viviamo, che abbiamo
dentro; è il sentimento, la forza, l'energia. Religione e Fede sono due cose
completamente diverse: religione è quello che facciamo, l’insieme delle nostre
pratiche; la fede invece è la vitalità, l'energia, la passione che mettiamo nel
farle. Esattamente come nella vita normale: la religione è il comportamento
esteriore, sono i regali, le attenzioni per la persona amata, la cortesia, la
galanteria: i fiori, un anello, un invito a cena. La fede è invece l’amore, la
forza del sentimento che percepiamo dentro di noi, la passione che nutriamo per
lei, il desiderio che ci brucia nel cuore. Tutto chiaro?
Quindi:
da come reagiamo di fronte alle piccole cose, come pure davanti alle
difficoltà, agli imprevisti, agli ostacoli della vita, possiamo misurare la nostra
fede, la nostra fiducia in Dio. Certo, la fede non elimina materialmente i
problemi e le difficoltà: ci dà però sicuramente la pace e la serenità per
poterli affrontare. L'uomo di fede vive con una fiducia profonda: “Io sono
protetto da Dio; Lui è con me. Se Lui è con me, di cosa ho paura? Perché mi
devo preoccupare? Perché devo temere?”. In questo modo affronta ogni cosa con
una tale energia da riuscire a piegare veramente gli eventi e le situazioni a
suo favore.
Il “gelso”
però, oltre che le difficoltà materiali, rappresenta anche i nostri schemi mentali
malsani, le nostre abitudini distorte, le nostre convinzioni egoistiche; i nostri
schemi ci danno sicurezza, sono conosciuti, ci fanno agire in maniera
automatica, senza fatica; anche se spesso sono inutili, inconcludenti. Aver
fede, in tal caso, vuol dire: “Riconosco i miei automatismi, che mi fanno
vivere come un robot, e li rompo”. Spacco, spezzo, cambio le dinamiche
automatiche che vivo senza neppure sapere di averle. Mi credo libero e invece
sono un manichino che reagisce in maniera predeterminata. Più vivo di
automatismi, di pensieri fatti, di idee degli altri, di frasi ricorrenti e
preconfezionate, di ciò che fanno e pensano gli altri, più mi immedesimo negli
altri, uniformato, adeguato, adattato al sistema; e più sono condizionato, meno
padrone di me stesso, meno libero.
Fede,
fiducia, vuol dire che le cose si possono fare in maniera diversa. Fede,
fiducia, vuol dire che ciò che sembra impossibile si può affrontare.
Attenzione
però, perché c’è anche il rovescio di questa medaglia: ed è la “fissazione”, l’esatto
contrario di “fede e fiducia”. “Fissazione” è quando, di fronte al mutarsi di una
idea, di una situazione, di un comportamento, noi reagiamo sempre allo stesso
modo: ci siamo “fissati”, fermati, e non c'è verso di cambiare prospettiva, posizione.
“Fissazione” è quando noi stessi siamo il “gelso”, ostinati sulle nostre posizioni,
cocciuti e testardi; per paura di cambiare (abbiamo fatto sempre così!), e di
ciò che comporta, ci ostiniamo a percorrere la solita strada, quella conosciuta
e più facile, anche se senza uscita.
La
nostra società è piena di fissazioni. Persone che, quando hanno deciso una cosa,
rimane quella per tutta la vita, anche se continuano a sbatterci contro. La
fissazione impedisce di crescere in quanto esclude ogni possibilità di trovare strade
alternative, più consone alla situazione. Molte persone, in questo modo, si
sono create una loro personale realtà. Un'idea sull'amore? l'amore è così.
Un'idea su Dio? Dio è così. Un'idea sulla politica? la politica è così. “Questa
cosa si fa così e basta”; “quella persona, per quanto possa fare, sarà sempre
così, non cambierà mai!” (è una sentenza di morte!).
La
fede, al contrario, è innanzitutto elasticità; è non rimanere ancorati,
fissati, sclerotizzati nelle rispettive posizioni, idee, schemi. Fede è poter
cambiare, poter divenire. Fede è dare nuove possibilità alle persone, è credere
nel Dio che le abita. Fede è donare fiducia.
E
concludo: abbiamo fede, abbandoniamoci nelle braccia di Dio; ma questa volta facciamolo
sul serio, non come siamo soliti fare, per finta, a parole.
Purtroppo
abbiamo la brutta abitudine di ricordarci di Dio soltanto quando stiamo con
l'acqua alla gola, quando ci accorgiamo di non farcela più; e mettiamo Dio alla
prova. Gli diciamo che ci fidiamo di Lui, ma lo facciamo solo apparentemente; sappiamo
solo parlare e straparlare, ma non abbiamo la fede e il coraggio di camminare
sulle acque, di staccarci dalla riva, andare al largo e raggiungerlo. Eppure
Lui ci ascolta sempre, e spesso lo fa anche in maniera così totale e clamorosa da
spiazzarci completamente, mettendoci in condizione di dovergli dare delle
risposte finalmente coerenti.
A
volte la nostra vita è irrequieta, piena di dubbi, di ansie: ma ci guardiamo
bene dal ricorrere a Lui con fede, per paura di dover poi cambiare; Lo invochiamo,
ma non gli lasciamo nessuna possibilità di agire e di salvarci; lo invochiamo, è
vero, ma pretendiamo anche di spiegargli cosa deve fare.
Allora,
vogliamo essere veramente suoi discepoli? Mettiamo la nostra vita e la nostra
volontà nelle sue mani: ma per davvero, sul serio! Pregando con fede e come si
deve.
A
questo proposito un prete, in modo scherzoso (ma non troppo), metteva in
guardia i suoi parrocchiani: “Non affliggete troppo Dio con le vostre continue
lamentele, con le vostre continue preghiere di insoddisfatti cronici; ricordate
che l’unico, serio rischio, delle vostre preghiere è che Dio le ascolti; e così
l’unica cosa che vi rimane poi da fare, è diventare santi sul serio, con i
fatti, non a chiacchiere!”.
Un’ultima
provocazione per concludere: non dimentichiamoci mai che, nonostante tutto quello
che facciamo, siamo sempre “servi inutili”. In ogni caso. Evitiamo allora di
armarci di quel sacro “zelo” così fuori luogo; non imbarchiamoci in “sante
crociate”, per le quali siamo completamente inadeguati. Impariamo invece a
stare umilmente al nostro posto. Quello che Gesù vuole da noi è che viviamo da
uomini di grande fede, che andiamo avanti per la nostra strada con un cuore umile
e caritatevole, stracolmo di pace, completamente aperto all’accoglienza dei
nostri fratelli. Con gioia, riconoscenza, serenità. Nient’altro. Accantoniamo quindi
definitivamente le nostre arie di superiorità, sempre inopportune e
commiserevoli, e lasciamo fare a Dio il suo mestiere. Anche perché, detto tra noi, non
abbiamo assolutamente nulla da insegnargli. Amen.
«C’era un uomo ricco, che
indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe,
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i
cani che venivano a leccare le
sue piaghe…» (Lc 16,19-31)
Ad un
primo veloce approccio col Vangelo di oggi, si potrebbe concludere che i ricchi
vanno all'inferno e i poveri in paradiso. Quindi, visto così, sarebbe un invito
per i poveri a sopportare con pazienza le miserie di questa vita, in vista di
una ricompensa lassù: fermo restando che quaggiù i poveri rimarrebbero sempre
poveri e i ricchi sempre ricchi.
Il
senso della parabola però è molto più profondo e indica in realtà quello che ci
accadrà se continueremo a vivere disinteressandoci degli altri, del bisognoso che
bussa alla nostra porta, mentre noi facciamo finta di non vedere quello che ci succede
intorno, quello che, per qualche tornaconto, non vogliamo vedere e che invece dovremmo
vedere.
Nel
vangelo ci vengono proposti due personaggi, il ricco e il povero. Il ricco ha
tutto: vestiti di porpora e bisso (segno di grande agiatezza e di alta
posizione sociale), una casa, cibo a volontà, che gli consente ogni giorno di mangiare
lautamente e abbondantemente; ha “fratelli”, cioè relazioni, amici, amore; ha
una sepoltura (cosa che solo i ricchi potevano permettersi a quel tempo). Il
ricco insomma ha tutto, non gli manca niente. L'unica cosa che non ha è un
nome.
Poi
c'è Lazzaro. Lazzaro non ha proprio nulla. Non ha casa, non ha cibo né amici (è
solo con i cani!) e non ha nemmeno sepoltura. Lazzaro è indifeso, è mendicante,
bisognoso, malato, ricoperto di piaghe, affamato e solo. L'unica cosa che
possiede è un nome: Lazzaro, che vuol dire “Dio
aiuta”.
Ebbene:
per la Bibbia avere un nome è fondamentale, perché il nome identifica una
persona, è la persona stessa. Conoscere il proprio nome significa conoscersi,
avere un'identità, una strada da percorrere, qualcosa da realizzare, essere
vivi. Lazzaro, “Dio aiuta”, è il povero;
il suo nome è la sua vita: ha bisogno di Dio, ha bisogno che qualcuno lo aiuti,
che Dio si prenda cura di lui e che lo salvi dalla sua condizione.
Il
ricco, invece, no. Quasi sempre i ricchi del vangelo di Luca non hanno nome. Il
ricco non ha nome perché è incosciente, non si conosce, vive nella superficialità,
si disinteressa completamente di ciò che succede alle porte di casa sua, e per
questo non ha alcun potere sulla sua stessa vita.
Il
ricco non si accorge di Lazzaro: non lo vede neppure; ma come avrà fatto a non
vederlo? Era lì... alle porte di casa sua... tutti i giorni a mendicare:
chiedeva aiuto e urlava il suo disagio.
Questo
è il grave problema del ricco, questa è la sua condanna: il non accorgersi. E una
stessa condanna sarà riservata anche a noi, ci dice il vangelo, se vivremo non accorgendoci
dei Lazzaro nostri fratelli, ma soprattutto del Lazzaro che è in noi: non
accorgendoci, cioè, del bisogno, del disagio della nostra anima, della nostra coscienza
che urla, che strepita, che vuole la nostra attenzione, e che noi lasciamo
fuori, alle porte della nostra casa.
L'inferno
e il paradiso sono nelle nostre mani. Tocca a noi decidere se ospitare in casa nostra
Lazzaro o se lasciarlo fuori.
L'inferno
o il paradiso ce lo scegliamo noi: se facciamo i “ricchi”, se sfarfalliamo, se chiacchieriamo
a vuoto, se non ci poniamo mai domande serie da scuoterci l’anima, se non affrontiamo
mai questioni vitali, profonde; se ci guardiamo bene dallo scavare dentro di noi,
se evitiamo insomma le difficoltà, i problemi, se evitiamo il bene perché è
scomodo e ci dà fastidio, se in una parola non ascoltiamo la voce della nostra coscienza,
finiremo sicuramente all'inferno, alla perdita dell’amore eterno.
Dobbiamo
pertanto convertirci: la conversione è il passaggio che facciamo dall’inferno
al paradiso, è il momento stesso in cui smettiamo di lusingarci da “ricchi”, e
accettiamo, pur con dolore ma con un senso di liberazione e sollievo, che siamo
tanti Lazzaro. È in quell'istante infatti che potremo sperimentare con mano che
veramente “Dio salva”.
Noi siamo
i Lazzaro: siamo i soli, gli indigenti, i pieni di miserie. Siamo i soli,
perché in casa nostra non abbiamo proprio nessuno.
È
triste ammetterlo, ma quante volte nella vita, siamo stati Lazzaro: quante
volte ci siamo trovati anche noi a dover “mendicare” amore, affetto, comprensione,
e non è arrivato nulla!
Fa male
aver bisogno di amore; fa tanto male dover chiedere amore, riconoscere che ne abbiamo
bisogno. Fa male tendere la mano per ricevere, dover mettere a nudo la nostra
anima per poter essere nuovamente accettati, perché qualcuno possa farci entrare
nella sua “casa”: abbiamo il terrore di venire nuovamente feriti. Siamo deboli
e vulnerabili, anche se ostentiamo sicurezza e presunzione. Del resto non è facile
accettare di essere Lazzaro: di dover mendicare amicizia, calore umano, di doverci
accontentare di briciole d’amore, convinti che in fondo “qualcosa” è sempre
meglio di niente! In certi momenti siamo addirittura pronti a scendere a dei
compromessi con noi stessi, a permettere agli altri di fare di noi quello che
vogliono, pur di avere in cambio un riconoscimento, calore, comprensione, sostegno.
Non ci
piace vederci come Lazzaro che, solo e abbandonato, bussa ad una porta a cui
nessuno apre, un Lazzaro che nessuno vede né sente; essere Lazzaro ci fa
vergognare, ci fa soffrire.
Ma è
molto peggio essere i “ricchi”, perché significa trasformare la nostra vita fin
da ora in un inferno. Si, perché l'inferno è solitudine; inferno è chiudere per
sempre la porta di casa nostra, sbarrarla e impedire a chiunque di entrare. L'inferno
è “chiusura”: è impedire a Dio di entrare con la sua luce, per portare ascolto,
liberazione, pace, perdono e misericordia là dove c'è tormento, solitudine e
sofferenza.
L'inferno
o il paradiso è quindi nelle nostre mani.
Tocca
a noi decidere pertanto se ospitare in casa nostra gli altri Lazzaro, quelli
che ci sono vicini, o se lasciarli fuori: dei Lazzaro che urlano, ma che noi
non sentiamo. Ma se ci stanno urlando perché stanno male, guardiamoli una buona
volta, e accogliamoli! Se ci stanno urlando silenziosamente la loro paura, le
loro angosce, accorgiamoci delle loro urla silenziose, accogliamoli e
ascoltiamoli. Come facciamo a non accorgerci che nostra moglie, nostro marito,
il nostro partner, i nostri confratelli, i nostri amici, hanno bisogno del nostro
amore, delle nostre parole, della nostra presenza? Come facciamo a non vedere che
i nostri figli, i nostri nipoti, hanno bisogno di noi, del nostro incoraggiamento,
del nostro apprezzamento? Non vediamo che i nostri fratelli soffrono, che hanno
la tristezza e il pianto negli occhi? Non vediamo, non sentiamo l'angoscia di
chi ci vive a fianco? Non vediamo i dolori e i pesi che si tengono dentro? Eppure
questi Lazzaro ci sono così vicini, fuori della nostra porta: ma noi siamo occupati
nelle nostre cose, occupati nei nostri affari, nel “giardino” della nostra casa,
e non diamo loro ascolto.
Nella
seconda parte del vangelo c'è poi la preghiera del ricco che vorrebbe andare
dai suoi fratelli perché non facciano la sua stessa fine. Ma – interviene Abramo
– ciò non è possibile. Del resto, se uno ha il cuore indurito, neppure davanti
a Cristo in persona crederebbe.
I
segni ci sono: chi vuol vedere vede, chi non vuol vedere non vedrà mai. Molte
persone vivono una vita da sordi, non hanno orecchie per ascoltare, vivono
senza udire le voci degli uomini di Dio che li ri-chiamano. Molte persone hanno
vicino “Mosè e i Profeti”, hanno profeti e persone, possibilità ed esperienze
per poter sentire e crescere, occasioni che ricordano loro di prendersi cura di
Lazzaro, della loro anima, del loro mondo interiore, di chi soffre vicino a
loro, di coltivare la propria sensibilità. Non sono i miracoli che salvano, è
la fede. Esseri vivi e svegli al mattino è davvero un miracolo; i computer più
sofisticati fanno semplicemente ridere di fronte al miracolo della vita: ma
tutto questo neppure ci sfiora. Siamo immersi in un continuo miracolo che si
chiama vita, ma tutto questo non ci stupisce né ci commuove. E chi non vuol
credere, non crederà neppure se i morti resuscitano.
Noi
siamo esseri di luce e di ombra. Siamo contemporaneamente l'uomo ricco e anche
Lazzaro; siamo ciò che ci piace, ma siamo soprattutto ciò che rifiutiamo, che
non vogliamo accettare e accogliere nella nostra vita, che è doloroso, insostenibile;
siamo esseri divini, ma anche terribilmente umani. E se ci nascondiamo una cosa,
non vuol dire che non ci appartenga.
Il
grande compito della nostra vita è portare luce dove c'è buio. Ma chi vuole aver
a che fare col buio? Nessuno. Perché il buio ci spaventa, ci angoscia, ci fa
terribilmente paura. Chi vuole entrare con la propria flebile luce in certi
inferni della vita? Ovvio, nessuno. L'ignoranza è l'illusione di credere che
certe cose non esistono solo perché non le vediamo. Eppure è proprio questo che
la vita ci chiama a fare. Entrare negli altri con la luce di Dio, della
coscienza, della consapevolezza, con la fiducia e con la forza del Padre, per
portare luce e liberazione negli inferni delle anime. L'inferno è tale perché è
buio; ma se c'è una luce, per quanto debole sia, anche il buio più pesto può
diventare abitabile.
Noi
siamo figli della luce, noi siamo figli di Dio: non dimentichiamolo.
Il
diavolo, il male, ama il buio, il sotterfugio, il nascondimento, l'anonimato,
la notte, l'oscurità. L'ignoranza è il peccato più grave: vuol dire lasciare
nel buio, nell'anonimato, nel nascondimento, ciò che chiede di essere portato
alla luce. Anche il ricco ignorava Lazzaro, ed è per questo che ha creato il
suo inferno. Il buio è ciò che non sappiamo, ciò che ci spaventa, ciò che
evitiamo. Vera spiritualità è portare luce nelle tenebre della nostra vita; è
portare consapevolezza nell'ignoranza della nostra esistenza; è vedere tutto
ciò che è Lazzaro.
Per
chi vive al buio, per i figli delle tenebre non c'è possibilità di salvezza;
solo i figli della luce, solo chi avrà la fiducia di non nascondersi nulla e di
far entrare la luce di Dio nella propria vita potrà salvarsi e potrà vivere.
C'è
una storiella: è sera e un uomo sta cercando in casa sua qualcosa. Arriva un amico
e gli chiede: “Cosa cerchi?” “Cerco le chiavi dell'auto”. Allora anche l'amico
si mette ad aiutarlo ed entrambi cercano per un bel po' in quella camera. Ad un
certo punto l’amico gli chiede: “ Ma dove di preciso le hai perse?”. “Le ho perse
in cantina”. “Ma diamine, perché cerchiamo qui allora?”. “Perché qui c'è più
luce!”.
Si
potrebbe anche ridere, se non fosse che questa storiella ci propone una grande
realtà.
Noi
tutti preferiamo muoverci dove c’è luce, sicurezza, serenità: preferiamo non
lasciarci coinvolgere dal buio, dalle difficoltà della vita presente, dalle
necessità del prossimo. Ma come pensiamo di raggiungere la luce, la felicità,
l’amore eterno di Dio, se ignoriamo il richiamo del nostro fratello Lazzaro, e
lo lasciamo morire davanti alla nostra porta? Noi abbiamo il terrore della
cecità degli occhi: ma per quella del cuore nessun timore ci sfiora. Pensiamoci.
Amen.
«Che cosa farò, ora che il mio
padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi
vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua» (Lc 16,1-13).
Riconosciamolo:
la parabola del Vangelo di oggi ci imbarazza non poco e suscita in noi un
notevole disagio: come fa Gesù a lodare uno che ruba? Un disonesto? Possibile che
Gesù abbia detto proprio una cosa del genere? Ebbene: le parole sono proprio sue.
Soltanto che Gesù non intende lodare l'amministratore per ciò che ha fatto,
come potrebbe sembrare ad un approccio superficiale col testo. Non dice: “Ha
fatto bene a fare così” e quindi: “Se ti è possibile fai anche tu altrettanto!”.
Gesù, al contrario, di quel contabile disonesto si limita a lodare solo la capacità
di reagire ad una situazione compromessa: il darsi da fare cioè di uno che non
si rassegna, che non si butta giù, che non “piange a vuoto”, ma che trova a
tutti i costi la soluzione definitiva ad un problema apparentemente
irrisolvibile.
Dove infatti
il testo dice: «Il padrone lodò
l'amministratore disonesto», appare evidente che si tratta di una traduzione non
proprio corretta: è impensabile infatti che un padrone, per quanto bravo e santo
sia, accortosi di essere stato derubato dal suo amministratore, gli dica: “Complimenti,
hai fatto proprio bene! Hai tutta la mia stima!”.
Per capire
il vero senso del testo, era sufficiente tradurre il termine greco “κυριος” del
versetto 8, invece che con “padrone”,
con “Signore” (è infatti “κυριος” l’appellativo
più ricorrente per indicare Gesù: Luca lo usa ben 103 volte nel Vangelo e 107
negli Atti); in questo modo la frase diventerebbe immediatamente comprensibile:
“Il κυριος (il “Signore”, cioè Gesù”) lodò il comportamento dell’amministratore”. Non è il padrone, dunque, ma è Gesù
che loda l’uomo, è Gesù che sottolinea, come esempio da seguire, non ciò che
lui fa in concreto, ma il modo con cui lo fa; loda la sua immediata reazione, la
sua prontezza nel prendere una decisione, la sua determinazione nel voler rimediare
ad una situazione imprevista. Non si è stracciato le vesti, non si è disperato,
non si è messo a urlare a vuoto, non ha chiuso gli occhi aspettando la
soluzione chissà da chi. In pillole insomma Gesù vuol dire: “come miei
discepoli, non dovete assolutamente essere delle persone “dormienti”,
imbambolate, inconcludenti, persone cui sta bene tutto, vada come vada. Dovete
essere reattivi, responsabili, pronti a rimettervi in piedi se cadete, ad
essere propositivi, esattamente come quell’amministratore, uno che ha saputo
valutare molto bene le sue reali possibilità”. In questo modo lo schema da
seguire, così come ci viene indicato, è molto semplice: ci accorgiamo che in
una certa situazione non possiamo più “lavorare”? Che quella strada che avevamo
imboccato non è più praticabile? Basta, inutile tergiversare: dobbiamo
immediatamente trovarne un’altra, dobbiamo agire in un altro modo, con un'altra
logica; dobbiamo fare scelte mirate, più creative, concrete; in una parola dobbiamo
correre subito ai ripari, inventarci un rimedio veloce ed efficace.
Quando
una cosa non funziona più, è inutile insistere, lottare, illudersi che possa
cambiare. Quando una cosa non funziona più, dobbiamo semplicemente cambiarla.
L’area
di applicazione più ovvia di questi insegnamenti, è quella del nostro comportamento
di fronte alla colpa. Abbiamo sbagliato, ci siamo comportati egoisticamente,
abbiamo calpestato i nostri principi, abbiamo tradito noi stessi, la fiducia e
i diritti degli altri? Se siamo già caduti così in basso, inutile recriminare,
inutile continuare all’infinito a lacerarci l’anima. Seguitare a rimuginare sul
male fatto, su cosa avremmo dovuto fare e non l’abbiamo fatto, su come avremmo
dovuto farlo, non serve assolutamente a nulla: ormai è successo. Certo: siamo
stati degli sprovveduti, dei superficiali, troppo sicuri di noi, parecchio stupidi
ed egoisti; ma a questo punto vogliamo forse morire? A che serve farla finita, morire
(dentro o fuori che sia)? Cosa risolviamo? Ciò che è stato è stato. Ma se il
passato non si può cambiare, siamo noi però che possiamo cambiare: siamo noi
che dobbiamo imparare a non ripetere il male; a chiedere perdono a Dio e al
prossimo, a riparare per quanto possibile al danno che abbiamo procurato; siamo
noi, insomma, che ci dobbiamo correggere, che dobbiamo perdonarci e risorgere
con nuovo slancio.
Nel
vangelo è dunque la risolutezza dell'amministratore che viene lodata: non si
lascia annientare dal fatto di essere colpevole di frode; non si arrende. Quante
persone invece dopo un errore, dopo una colpa, anche se non grave, si lasciano
andare completamente, non reagiscono, non alzano un dito per tornare come
prima.
Invece,
abbiamo rubato? Abbiamo tradito il partner? Abbiamo completamente sbagliato nell’educare
i figli, ecc.?; certo sono fatti oggettivamente gravi, concreti. Ma non
perdiamo tempo: prendiamo immediatamente in mano la situazione, rialziamoci e
corriamo dal medico per le cure del caso. È l’unico modo per salvare il salvabile
e riacquistare la nostra dignità. Qualunque cosa facciamo, dobbiamo perdonarci.
E perdonarci, significa riconoscere il mal fatto, provarne un sincero
dispiacere; non tanto in noi stessi, per conto nostro, nella nostra testa, ma
di fronte a “qualcuno” che può a sua volta perdonarci in nome di Dio. Dopo di
che rialziamoci, e torniamo a vivere nuovamente liberi, a testa alta.
Altra
indicazione del vangelo di oggi è che dobbiamo accorgerci degli altri, dei
nostri fratelli, di quelli che vivono al nostro fianco, e aiutarli. Come ha
fatto l’amministratore infedele; finora egli aveva “sfruttato” le persone, le
aveva trattate senza cuore e senza umanità; per lui era tutta gente da spremere
il più possibile. Ora invece si accorge che quelli con cui trattava, non sono
oggetti, sono degli uomini, delle persone. E come mai se ne accorge? Perché
anche lui ora si trova nella stessa loro condizione. Anche lui adesso è un “debitore”
del padrone, esattamente come loro. Anche lui ora vede le cose dalla loro
stessa prospettiva. Ed è in questo momento - quando cioè è caduto in basso,
quando è costretto a vivere le stesse esperienze negative dei miseri, a dover affrontare
le loro stesse situazioni compromesse, le stesse colpe - che nasce in lui la
misericordia. L’uomo perfetto, quello al di sopra di tutti, quello che non
sbaglia mai, non conosce la misericordia, non sa cosa sia, non potrà mai usarla;
non potrà mai dispensare comprensione, amore, al debole che cade, perché lui
non è un debole e non conosce alcuna caduta. Lui, l’impeccabile, non può che appellarsi
alla legge, alle regole, alle norme, e trattare i deboli soltanto con superiorità.
Solo chi ha sperimentato sulla sua pelle cosa voglia dire sbagliare, sentirsi
uno schifo, sentirsi indegni, colpevoli, può apprezzare la misericordia, il
bisogno tormentoso di perdono, di amore, di conforto. Chi non sbaglia mai, non
può che giudicare gli altri con disprezzo. Chi non sbaglia mai non conosce il Dio
dell’amore e della misericordia; lui non ne ha bisogno, non deve chiedergli
nulla; l’amore di Dio per lui è un diritto.
Tutti in
genere riconosciamo apertamente di sbagliare, di essere peccatori: ma la
maggior parte di noi, nel loro intimo, sono convinti di non esserlo poi così
tanto. Il vero guaio, in questi casi, non sta tanto nel fare o non fare degli
errori, ma nel non voler riconoscere quelli che facciamo; così, pur professandoci
peccatori, continuiamo a considerarci persone brave, oneste, rette. Salvo poi
essere i critici più spietati con quanti vediamo cadere.
Ebbene,
è su questo che dobbiamo lavorare: l'uomo del vangelo, come abbiamo detto, trasforma
radicalmente il suo modo di pensare e di agire: prima, egli spendeva tutte le
sue energie per defraudare i “debitori”; dopo, le sfrutta tutte per aiutarli. E
ci mette in questo tutta la sua passione, la sua grinta, la sua scaltrezza.
Trasforma cioè una serie di errori compiuti nel passato, in un impegno, serio e
attuale, di raddrizzare una situazione compromessa.
Il “perfetto”,
l’integro, l’osservante, non può conoscere questo tipo di “conversione”; il “perfetto”
non si espone, non ne ha bisogno, perché lui non ha colpe nascoste, non ha lati
distorti da raddrizzare.
Gesù stesso
non è tanto preoccupato per il nostro sbagliare. Egli è molto più preoccupato del
nostro non ammettere l’errore, del nostro far finta di niente, del nostro comportarci
come se tutto fosse in ordine, a posto; quando invece a posto non lo siamo
affatto.
È poi molto
importante, a questo proposito, essere consapevoli che il nostro continuare a
vivere nella colpa, nell’indifferenza, con una condotta amorale, con degli
scheletri putrefatti nell’armadio della nostra coscienza, sono non solo delle
zavorre che ostacolano il nostro progresso spirituale, ma anche delle miserie,
delle tare, dei “geni patogeni” che trasmettiamo in qualche modo alla nostra
memoria biologica: nel senso che i nostri figli subiranno inconsapevolmente le
conseguenze di questa nostra ostinata incoscienza: se infatti nella nostra vita
siamo permissivi in tutto, se siamo incuranti dei valori, se non dimostriamo ai
figli di essere obiettivi, onesti, di saperci assumere le nostre
responsabilità, di ammettere i nostri errori, di riparare ai torti fatti, di
avere il coraggio di chiedere perdono, sarà naturale per loro imitare e reiterare
nella loro vita questi nostri esempi negativi: otterremo cioè, con molta
probabilità, dei figli irresponsabili, indifferenti ad ogni valore morale
irrinunciabile, a Dio e alla famiglia…
Pertanto
se ci accorgiamo di vivere una vita vuota, se sentiamo su di noi il peso delle
nostre colpe, non continuiamo a fingere, non rimaniamo un minuto di più in tale
situazione. Facciamolo per noi e per chi amiamo. Così, se ci sentiamo in colpa
perché non siamo quelli che vorremmo, non rimandiamo sine die il nostro cambiamento, diamoci da fare, non è mai troppo
tardi! Non deludiamo noi stessi e i nostri figli con il nostro far nulla: pentiamoci
seriamente, invece, buttiamo tutte le nostre deficienze alle spalle, e
perdoniamoci: si, perdoniamoci! Ci sentiamo in colpa perché abbiamo un
carattere difficile, perché non riusciamo a dominare i nostri istinti, i nostri
scatti d’ira, perché ripetiamo all’infinito i soliti errori? perdoniamoci! Solo
così ci libereremo dall’influsso nefasto delle nostre colpe. Ma cosa significa
in definitiva questo “liberarci”, questo “perdonarci”? Significa confessare a
Dio le nostre miserie, significa riconoscere umilmente di aver sbagliato e ammettere
il nostro errore, significa chiedere perdono a Lui e a chi abbiamo in qualche
modo danneggiato; significa riparare per quanto possibile al danno commesso. Solo
in questo modo riusciremo a vivere da perdonati, da liberi, da graziati: perché
solo in questo modo, potremo nuovamente trasfigurarci nella gioia, nella luce e
nell’amore del Padre. Amen.
«Un uomo aveva due figli. Il
più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze…»
(Lc 15,1-32).
Questo
brano del vangelo ha molte chiavi di lettura: è la storia di Dio Padre che aspetta
il ritorno a casa di ogni figlio smarrito, e lo accoglie sempre a braccia
aperte. È la storia di quei giovani in procinto di affacciarsi nel mondo: per
poter trovare se stessi, la propria vita, la propria collocazione nella società,
devono prima “uscire” da una mentalità ristretta, chiusa, infantile. È la
storia di ogni uomo, di tutti noi, che a volte possediamo le cose ma non ce ne
rendiamo conto; da qui la necessità di capire, di apprezzare e riconoscere quello
che già possediamo: ci sono differenze infatti che non potremo mai cogliere stando
rintanati in noi stessi, ma solo “uscendo” da noi, vivendo, magari sbagliando,
ma provando e riprovando. È la storia di come possiamo fare tante “cavolate”
nella vita; ma anche di come non sia mai troppo tardi per rimediarvi: possiamo finire
con i porci, condurre una vita depravata, razzolare tra i rifiuti, ma abbiamo sempre
la possibilità di redimerci, di recuperare la nostra vita e soprattutto riacquistare
la nostra dignità. È la storia dell'amore che rimane, che vince su tutto: è la
storia di quel padre che, al di là dell'evidenza, al di là del dolore, al di là
del rifiuto ricevuto dal figlio, al di là di tutto, continua a rimanere un
padre affettuoso, un padre innamorato del figlio. È la storia di chi ha paura
di crescere, di cambiare: di chi se ne sta chiuso in se stesso, con le sue
solite idee, con il suo solito lavoro, nel suo solito mondo, e muore: muore
perché la sua non è vita, vivere non è questo: non è vita quella del figlio
maggiore che dichiara un depravato, un morto, suo fratello, e non si accorge
che sta parlando di sé; è lui che è un morto in casa, è lui che è corroso e
paralizzato dalla paura; e cosa fa? Giudica! Giudica il fratello perché non
riesce a vivere come lui, e ciò lo infastidisce profondamente. Il giudizio è
sempre la voce della morte: attacchiamo l’altro, perché noi non siamo in grado di
imitarlo e vivere la vita come fa lui.
Ecco,
queste sono alcune possibili chiavi di lettura di questo vangelo. Più in
generale esso ci propone la storia dell’uomo, l’evolversi della vita: ci descrive,
ci mostra con mano, come le nostre relazioni interpersonali, durante
l’esistenza, siano destinate a cambiare.
Guardiamo
meglio cosa succede. C'è un padre con due figli, e quindi, essendo in tre, ci vengono
descritte tre relazioni: quella tra il padre e il figlio minore; quella tra il
padre e il maggiore, e infine quella tra i due fratelli, il minore e il
maggiore.
Per
entrambi i figli il padre è colui “che dà”. Il figlio minore gli dice infatti: «Dammi la parte di eredità che mi spetta».
Quel “dammi” rivela chiaramente come lui consideri suo padre: suo padre è colui
che gli deve “dare”. Anche il figlio maggiore la vede in questo modo, e gli
rimprovera: «Tu non mi hai dato mai un
capretto per far festa con gli amici».
Tutti
i figli, in fondo, vedono il padre e la madre in questo modo: come coloro cioè che
devono “dare” sempre: il cibo, i vestiti, la casa, i soldi per i libri, per mangiare
la pizza con gli amici, per uscire e divertirsi. Del resto, guai se non facessero
così: guai se i genitori non assicurassero ai loro figli sostentamento e
nutrimento: è la loro stessa funzione naturale quella di “dare”, fin dai primi
anni di vita: sono lì esattamente per quello.
E la
relazione tra i due fratelli? Non si rivolgono mai la parola. Non si diranno
mai niente: i due fratelli non s'incontreranno mai! Perché? Semplice: non “vogliono”
incontrarsi; entrambi sono in conflitto per il padre, un conflitto che però li
divide: vince il maggiore (il prescelto), perde il minore che se ne deve
andare.
Si
capisce allora perché egli si rivolga al padre in maniera così dura e perentoria:
“Dammi la parte del patrimonio che mi spetta”. Non a caso si rivolge così; non
perché abbia un caratteraccio, non perché sia un depravato. Si rivolge così
perché il padre ha scelto il maggiore (com'era normale e ovvio a quel tempo e,
per certi aspetti, in ogni tempo) e lui si sente rifiutato. Non è il preferito;
il padre ha scelto l'altro: e non essere scelti, non essere i primi, fa sempre molto
male!
Tra i due
fratelli c'è relazione, ma è una relazione di odio, di competizione, di
conflitto. Non si dicono niente ma si odiano “a sangue”: e risulta
particolarmente evidente quando il maggiore, rivolgendosi al padre, allude al
fratello chiamandolo “questo tuo figlio”: non lo vuol riconoscere come fratello,
per lui è soltanto un estraneo, uno che ha divorato i “tuoi averi con le
prostitute”, uno che merita solo odio e disprezzo. Egli si sente più forte: è
l'erede legittimo, e si sente quindi personalmente “defraudato”.
Il
minore invece, geloso del legame speciale esistente tra il fratello e suo
padre, si sente in netto svantaggio, e non può fare altro che andarsene. Anche
se la differenza che lamenta in fondo rientra nella normalità. Da che mondo è
mondo, infatti, i genitori non hanno mai trattato due fratelli esattamente allo
stesso modo; mai, in nessuna epoca, i figli hanno avuto da loro un trattamento
assolutamente paritario. Quando diciamo che i figli sono per noi tutti uguali,
ci illudiamo, facciamo solo della teoria. Non è così. Pensiamoci un attimo: il
primogenito, essendo il primo figlio, quello “atteso”, quello “desiderato”,
quello “cercato” e “voluto”, ha dai genitori un amore e una sollecitudine del
tutto particolare. Li ha tutti per lui. Il secondo non sarà mai come il “primo”,
perché non sarà più una novità, non procurerà più lo stesso impatto emotivo,
non richiederà lo stesso investimento di energie, né la stessa pianificazione del
primo. Il primo, poi, rispetto al secondo, è sempre “più avanti” nella scala
delle attese dei genitori: arriva prima a correre, a scrivere, a leggere, a
fare le cose; gode di maggior fiducia da parte della mamma, che lo ritiene più
bravo e responsabile, e gli da qualche piccolo incarico, a volte anche di
badare al fratello minore.
È
ovvio quindi che, agli occhi di quest’ultimo, sia lui il più bravo, lui il più
affidabile, e quindi anche, sia lui il preferito; è tutto ovvio e naturale. Ma
vedere uno che è sempre e comunque “più” di noi, essere costretti a dover lottare
continuamente per dimostrare che noi valiamo di più, sappiamo “di più”, possiamo
fare “di più”, beh, a lungo andare, distrugge anche i più forti.
Ebbene:
quello che il vangelo riporta è nient'altro che questo: il maggiore sa di
essere il primo, e il minore sa di essere il secondo.
Questa
perlomeno era la situazione iniziale, ma poi c'è stato un distacco, una
lontananza. C’è stato un viaggio salutare, che ha ridimensionato le cose: il
minore si è staccato dal padre, cioè dall’immagine di colui che deve solo “cedere”
il suo patrimonio, ed ha intrapreso quel lungo viaggio che l’avrebbe riportato dentro
di sé, sui suoi passi, sulle sue valutazioni (rientrò in se stesso). Anche il
padre ha dovuto fare un viaggio analogo, anche lui ha dovuto superare una immagine
distorta, rancorosa: quella di avere un figlio ingrato, ribelle, egoista, che
dopo aver ricevuto i soldi, invece di ringraziare, di dimostrargli riconoscenza
e amore, fa perdere le sue tracce; è cambiato al punto che lo troviamo in ansia,
fuori di casa, mentre attende angosciato il suo ritorno.
L’unico
che non ha fatto nessun viaggio è il figlio maggiore. Per lui suo padre è rimasto
“quello che dà”, e suo fratello continua ad essere per lui “quello inferiore”, il
depravato, il “porco”, quello che ha dissipato tutto con le prostitute. Egli è
spinto da invidia e da livore: non tollera che suo fratello, il “minore”,
quello che è sempre stato meno di lui, sia accolto in casa dal padre con una dignità
e con onori tali che neppure a lui, il fedele, gli erano mai stati
riconosciuti: per questo reagisce distruggendo il fratello, distruggendo la sua
immagine, infangandola, screditandola. Questo palese affronto alla sua superiorità,
al suo primato indiscusso, scatena in lui collera, rabbia, rancore. Il suo vero
problema è appunto non essersi mai mosso da casa; non essere uscito da se
stesso, non aver fatto alcun “viaggio” purificatore. Quante persone, rimaste
sempre ferme, tappate “in casa”, rivelano per questo tutti i loro limiti, la
loro chiusura mentale, le loro solite quattro idee, il solito modo di pensare,
le stesse cose e le stesse tradizioni di sempre. Per conoscere, per imparare,
per cambiare, bisogna uscire dal nostro microcosmo chiuso e limitato, bisogna mettersi
in discussione; uscire è scoprire immagini nuove, nuove cose incredibili;
uscire è rendersi conto che il mondo e la vita sono infinitamente più grandi
della nostra piccola e sclerotizzata testa. Ma uscire fa paura, è pericoloso,
ci mette in balia di forze avverse: non è forse meglio rimanere in casa, al
sicuro, soli e protetti dalle nostre personali certezze?
In
questo modo il minore, uscendo, rischiando, è cresciuto, è diventato uomo, ha
trovato la sua vita vera; il maggiore invece, trincerato nei suoi vecchi schemi
e pregiudizi, è diventato un uomo morto.
Al
ritorno del minore, dunque, sia lui che il padre sono completamente diversi: il
padre non è più “colui che dà” e lui non è più “colui che prende”, ma uno che a
sua volta “dà”.
E questo
figlio, coperto di stracci, senza più nulla, ma vinto dal dolore e dal rimorso,
cosa può dare ora al padre? Gli dà la gioia di esprimere la sua nuova vera paternità:
gli conferma cioè che essere padre non è più questione di soldi (patrimonio),
ma di amore, di affetto, di presenza (paternità). Il viaggio che lo ha portato
dal “patrimonio” (ti do le mie cose) alla “paternità” (ti do l'amore), è stato
determinante: essere padri non è dare cose, posizioni, uno status sociale;
paternità è dare qualcosa di sé, è poter essere una casa che rimane aperta ogni
volta che i figli vorranno tornare: e il “far festa con il vitello grasso”, altro
non è che una espressione di questo nuovo amore.
Sullo
sfondo, invece, il figlio maggiore sarà ancora lì, a discutere di capretti, di vitelli
grassi, di soldi risparmiati e soldi scialacquati: non ha capito la loro trasformazione;
lui non è ancora “passato”, non ha fatto ancora nessun viaggio, per lui l’immagine
del padre è sempre la stessa, quella di prima: e per questo si sente rifiutato.
Improvvisamente percepisce che il padre è radicalmente cambiato (“ama mio
fratello quanto me”), non accetta questo cambiamento, si scontra con questa novità
(“io non sono più il suo preferito”). E sempre per questo lo rifiuta e lo
attacca. Non ha capito che i rapporti nella vita devono cambiare; se non
cambiano muoiono o finiscono (che è la stessa cosa).
Le
relazioni non finiscono perché viene meno l'amore. Le relazioni finiscono
perché noi non vogliamo cambiare, ci irrigidiamo sulle nostre posizioni, ci
ostiniamo a rimanere fermi, ci opponiamo con tutte le forze a far “evolvere” il
nostro rapporto, farlo crescere, renderlo adulto.
Ma
questo, lo ripeto, non è vivere.
Le
scelte che la vita ci propone sono pertanto due: o uscire dalle nostre certezze,
rischiare di perderci, ma vivere poi nella felicità; oppure non muoverci, non
cambiare, fare cioè come il figlio maggiore, che dall’alto del suo legalismo
statico giudica e disprezza tutti, ma è infelice. A noi la scelta dunque, ben sapendo
che la nostra vita sarà condizionata da ciò che scegliamo. Amen.
«Se uno viene a me e non mi ama
più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le
sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non
porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo»
(Lc 14,25-33).
Di
fronte alla grande folla che lo segue, Gesù se ne esce anche questa volta con delle
parole molto dure. Per lo meno sembrano dure a noi che siamo abituati a
fermarci in superficie, senza curarci di approfondire, di capire in tutte le
sue sfumature il senso autentico dei suoi discorsi.
Gesù
dunque sembra freddare, scoraggiare la folla che lo segue. Ora, se ad una
importante manifestazione si verifica una folta partecipazione di pubblico, è
umano, naturale, che chi l’ha organizzata provi grande soddisfazione; infatti, il
massimo per chiunque abbia un messaggio da trasmettere, è sicuramente la
presenza di una folla che gli dimostra curiosità, interesse, ammirazione.
Gesù però non la pensa in questo modo: la gente con cui ha a che fare, è
eterogenea, spesso distratta, un po’ chiassosa; una folla che lo segue non
perché attratta dal suo messaggio “rivoluzionario”, ma per emulazione, per
fanatismo, per curiosità; tanto per fare qualcosa di nuovo, perché tutti fanno
così.
Egli non
ama le folle sterminate di questo tipo: Egli preferisce al suo seguito magari
poca gente, ma che sia convinta, motivata, che sappia quello che fa e quello
che vuole; gente che per seguirlo sia pronta a rinunciare anche agli affetti
più cari: «Chi non odia il padre, la
madre, il figlio, le sorelle non può essere mio discepolo».
Un
messaggio forte e chiaro: anche se in cuor nostro pensiamo che qui Gesù sia
andato un po’ oltre, che ci chieda veramente l’impossibile. Non ci aveva sempre
detto il contrario? Come possiamo “odiare” le persone più care al mondo?
Le
parole di Gesù, però, vanno oltre il loro significato immediato: Egli vuole
dirci che nella vita esistono due tipi di amore: uno buono, da coltivare, e uno
cattivo da evitare; un amore che ci rende liberi e un amore che ci rende
schiavi. C'è un amore che ci affranca, che ci redime, un amore che ci ridona a noi
stessi, alla nostra esistenza; e c’è un amore al contrario che ci ingabbia, ci
tarpa le ali, ci mortifica, ci imprigiona, un amore che ci lega indissolubilmente
a sé. Il primo ci libera, ci salva; il secondo ci uccide!
Viene
spontaneo allora chiederci: “Cosa c’entra tutto questo con l’amore per i propri
genitori? Se non è buono quello di amore, quale altro mai lo sarà?!”. Ma
andiamo per gradi: cerchiamo prima di tutto di scoprire e di capire con quale
amore noi amiamo, con quale amore veniamo amati, o come siamo stati amati nel
passato. Allora capiremo che non tutto quello che definiamo amore è “vero”
amore: possiamo infatti definire amore quello di chi ci obbliga a fare solo ciò
che vuole lui? Quello di chi condiziona una qualche dimostrazione di affetto,
di amore, alla perfetta esecuzione dei suoi ordini? Possiamo chiamare amore per
il prossimo, per il proprio compagno, per i fratelli, quello di chi tradisce la
loro fiducia, di chi si comporta in maniera disonesta, mirando solo al proprio
tornaconto? Purtroppo, il più delle volte, quello che noi chiamiamo amore,
altro non è che un travestimento dell’egoismo, dell’ingordigia, dell’avarizia,
della nostra avidità, del nostro amor proprio.
Ebbene:
in questi casi – dice Gesù - come pure in tutte quelle pseudo dimostrazioni
d’amore che sviliscono la nostra dignità di persone, che si frappongono cioè tra
noi e ciò che Dio vuole da noi, dobbiamo lasciare, dobbiamo distaccarci, dobbiamo
separarci, dobbiamo prendere un’altra strada. Anche se ciò coinvolgesse persone
a noi carissime, come i nostri genitori, i nostri cari.
Gesù
usa qui la parola “odiare” perché sa bene quanti sacrifici costi diventare
figli unici di Dio, diventare cioè “liberi”. Cosa c’è di più doloroso del dire
un “no” secco a chi amiamo, a nostro padre e nostra madre, pur di non tradire
noi stessi, la nostra vita, la nostra chiamata? Non fa forse paura l’abbandonare
una strada conosciuta, quella che in famiglia molti hanno già percorso prima di
noi, per seguire quella nuova, quella “nostra”, quella che Dio ci ha chiesto di
seguire in esclusiva, una strada completamente sconosciuta? È forse semplice
compiere il nostro viaggio in solitario, uscendo dalla massa, dal gregge? È piacevole
sentirci addosso la disapprovazione della gente, il loro biasimo, perché non ci
adattiamo come loro, non facciamo come loro, perché noi vogliamo il meglio? Non
sarebbe molto più semplice fare come fanno tutti, essere accettati dalla comunità,
dalla società, dagli altri, piuttosto che esporsi, avviarsi per una strada sconosciuta,
pur di realizzare noi stessi fino in fondo, nella nostra unicità di figli di
Dio, seguendo la Sua chiamata?
È
vero: noi per natura cerchiamo di assomigliare agli altri, di essere in tutto come
loro; ma Gesù ci ricorda qui che tutti noi, ciascuno di noi, siamo intimamente diversi
dagli altri: per cui se non abbiamo il coraggio di marcare questa differenza,
di “separarci” dagli altri, se non abbiamo il coraggio di vincere la paura
dell'abbandono, della solitudine, dell'impopolarità, dell'essere giudicati, se
abbiamo insomma paura di realizzare a fondo noi stessi, se siamo in qualche
modo attratti dalla mediocrità di un amore senza valore, non siamo degni di
Lui, non possiamo seguirlo, non possiamo incamminarci su quella strada, unica, esclusiva,
che Lui ha pensato e voluto solo per noi.
A
parlarne sembra un’impresa facile quella di seguire Gesù, ma non lo è! Perché seguirlo,
vuol dire percorrere quella stessa strada che lo ha portato al Calvario, alla
morte di croce. Ora capiamo finalmente perché Egli smonti con tanta crudezza i facili
entusiasmi di quelle persone che prendono tutto alla leggera, che considerano
la salvezza eterna come un diritto acquisito per il semplice fatto di chiamarsi
“cristiani”; di quelli che pensano di andare avanti per tutta la vita senza troppi
scossoni, mantenendo il piede su più staffe, dimostrando di essere senza testa e
senza cuore.
Nossignori:
nella vita per differenziarci, per distaccarci, per separarci, per vivere la “nostra”
esistenza, dobbiamo esporci, dobbiamo correre dei rischi notevoli; altrimenti non
ci sarà “vita” in noi; e il nostro spirito, la nostra anima, inesorabilmente moriranno.
Vivere la Vita di Dio, comporta il rinascere a noi stessi, l’essere autonomi, protagonisti,
l’essere unici: in una parola, riscoprire la nostra vera fisionomia che ci “differenzia”
dagli altri.
Purtroppo
la società in cui viviamo non ci è di alcun aiuto in questo: una società di
persone anestetizzate, drogate, smidollate, che vivono adagiate le une sulle
altre, che rinunciano a qualunque tratto identificativo della persona; anzi, una
società che calpesta impunemente lo stesso nobile concetto di “persona”, di “famiglia”.
E noi non ce ne accorgiamo! Non ci rendiamo conto che chi vive “attaccato” a
queste ideologie, chi è in simbiosi con esse, con la mentalità imposta da certo
mondo, è soltanto un parassita: perché vive questa sua squallida esistenza, succhiando
il sangue dai buoni, succhiando la vita da quelli che, nonostante tutto, perseverano
e faticosamente procedono nel loro cammino sulla retta via. «Chi non odia il padre, la madre, il figlio,
le sorelle non può essere mio discepolo».
Certo,
sentirsi amati è una cosa bella; godere di una posizione sociale invidiabile è una
cosa buona; come pure essere stimati, rispettati, essere belli e attraenti,
sentirsi in grazia; essere efficienti, organizzati, sapersi ben programmare:
sono sicuramente tutte cose buone, cose belle. Ma quando queste cose cominciano
a condizionarci, a mancarci troppo, ad essere indispensabili, allora diventano
una droga mortale. Allora ci attacchiamo ad esse con tutte le nostre forze, ci
leghiamo indissolubilmente ad esse, senza di loro non possiamo più vivere, abbiamo
il terrore di perderle. In quel momento non siamo più noi che dominiamo le cose
che ci servono, ma sono le cose che ci dominano, siamo praticamente schiavizzati
dalle cose. Non amiamo più le persone, anche se sentiamo un bisogno assoluto di
essere amati. In quel momento perdiamo la nostra libertà. Per questo Gesù ci dice:
“Staccati, separati da tutto questo. Se
vivi così non potrai mai essere te stesso, non troverai mai l’amore, ma rovinerai
la tua vita per sempre”.
Una
medaglia ha sempre due facce: l'amore è una faccia; l'altra è la libertà. Non
c'è amore senza libertà. L'amore è la faccia benevola, la faccia sorridente della
vita; la libertà è la faccia seria, esigente, quella del “dovere”. L'amore crea
“unioni”, la libertà crea “persone”. L'amore senza la libertà crea solo legami
di fusione apparente, di confusione, di paura. È come essere ancora attaccati
al cordone ombelicale. Non ci siamo sciolti,non ci siamo slegati, non siamo indipendenti,
autonomi. L'amore con la libertà crea invece persone vere, complete, autentiche,
persone che non marciano al ritmo dei tamburi della società, ma che seguono la
danza, il ritmo, la musica che sgorga dal loro cuore. Chi è libero può seguire il
Dio dell’Amore; chi è dominato riuscirà a seguire al massimo quegli idoli
“patacca”, che lui stesso si è auto costruito.
In
buona sostanza, Gesù oggi, con le sue parole, non intende dire che per seguirlo
dobbiamo “a priori” rinnegare il
padre, la madre, i figli, gli amici. Ma vuol dire: facciamo in modo che tutti i
nostri legami con le persone e le cose siano “liberanti”, siano cioè vivi,
affrancati da zavorre inutili e pesanti che ostacolerebbero il nostro cammino
verso Dio. Perché chi rimane impastoiato nei valori, nei legami di questo mondo, non
riuscirà a librarsi in alto, non potrà mai raggiungere quella libertà interiore
che gli permette di seguire fedelmente le orme di Cristo…
Liberiamoci
quindi da tutti quei legami che ci imprigionano, che ci condizionano, da tutte
le camicie di forza di questa società alienante. Rimaniamo liberi! Teniamo per
noi solo quello che ci serve per il cammino, senza farci trattenere o rallentare
da tutto ciò che uccide la nostra anima.
Ci
attende un grande compito nella nostra vita: diventare figli di Dio. Noi tutti
geneticamente proveniamo da una madre e da un padre. Ci piaccia o no, è così.
Noi siamo i loro figli. Non solo abbiamo in noi le loro somiglianze fisiche, ma
“prendiamo” dai nostri genitori anche le somiglianze caratteriali, emotive,
interiori. Siamo un miscuglio di nostro padre e di nostra madre. Ma il grande
compito della vita non è quello di diventare identici ai nostri genitori, ma di
diventare figli di Dio, perché è Dio il nostro vero Padre, e Dio-Vita, la
nostra vera madre. È la sua quella “somiglianza” perfetta che dobbiamo
raggiungere, quella stessa con cui siamo stati creati.
Se ci
fermeremo per diventare uguali a nostro padre e a nostra madre, avremo sicuramente
la loro stima, ma mancheremo l'obiettivo della nostra vita. Quando avremo esaudito
le aspettative dei nostri cari, del nostro parroco, del nostro capo, dei nostri
superiori, dei nostri amici, diventando esattamente come loro ci volevano, avremo
forse la loro ammirazione, ma mancheremo all'appuntamento con la nostra vita e
con il progetto che Dio ha sempre avuto per noi. Incontreremo forse il loro
riconoscimento, ma perderemo l’essenza di noi stessi, l’impronta originaria
impressa da Dio nel nostro cuore e nella nostra anima.
Per questo
Gesù, più avanti, ci mette in guardia anche dai facili entusiasmi; ci dice
praticamente che non dobbiamo illuderci, ma al contrario essere concreti, di fare
i conti con la realtà; dobbiamo cioè essere previdenti; dobbiamo agire e fare
le cose pianificandole, con cervello. Dobbiamo soprattutto valutare bene le
nostre forze, le nostre possibilità, e agire di conseguenza.
Per
non prendere cantonate dalla vita, nell’inseguire quelle che sono le nostre
aspirazioni, quello che vorremmo fare od essere, dobbiamo prefiggerci solo ciò
che obiettivamente possiamo fare ed essere, in base alle nostre reali
possibilità ed energie. Alcune persone continuano a fallire nella vita perché
si pongono obiettivi troppo alti, richiedono troppo da sé, non calcolano chi
sono realmente, cosa possono dare e di quanto possono disporre.
Dobbiamo
invece fare sempre i conti con la realtà, con la dura e cruda legge della
realtà. Perché la realtà è l'unica cosa che esiste, il resto è fantasia della
nostra testa. Noi vorremmo essere più semplici, più simpatici, più
intelligenti, meno ansiosi; vorremmo non aver detto quel “sì” o quel “no”; vorremmo
non aver fatto certi incontri; vorremmo che le persone che ci sono vicine
fossero diverse, che ci aiutassero di più, che si accorgessero di quanto
bisogno abbiamo del loro amore; vorremmo che la gente ci apprezzasse di più e
sparlasse meno di noi; vorremmo che nel mondo non ci fossero tutte queste
guerre e tutto questo odio; vorremmo avere meno impegni e costrizioni sociali,
e più tempo per vivere, più tempo per i nostri figli, per i nostri cari, per
noi, per ciò che ci appassiona. Ma la realtà, purtroppo, è ciò che viviamo, non
ciò che noi vorremmo.
Noi
siamo quel che siamo; viviamo in questo mondo, non in un altro. Questa è la nostra
unica esistenza, la nostra unica storia, la nostra unica possibilità di realizzarci,
di distenderci, di divenire. Tutto il resto, tutti i “Vorrei”, tutti gli “Oh come
sarebbe bello”, sono solo aspirazioni, sogni della nostra fantasia. Diceva un
vecchio monaco: “È stolto colui che avendo messo il piede su di un serpente,
chiude gli occhi per non vederlo, per cancellare la sua presenza: perché, anche così facendo, il
serpente lo morderà comunque!”. Svegliamoci, apriamo gli occhi, guardiamo dove
mettiamo i piedi, e viviamo senza farci false illusioni. Amen.